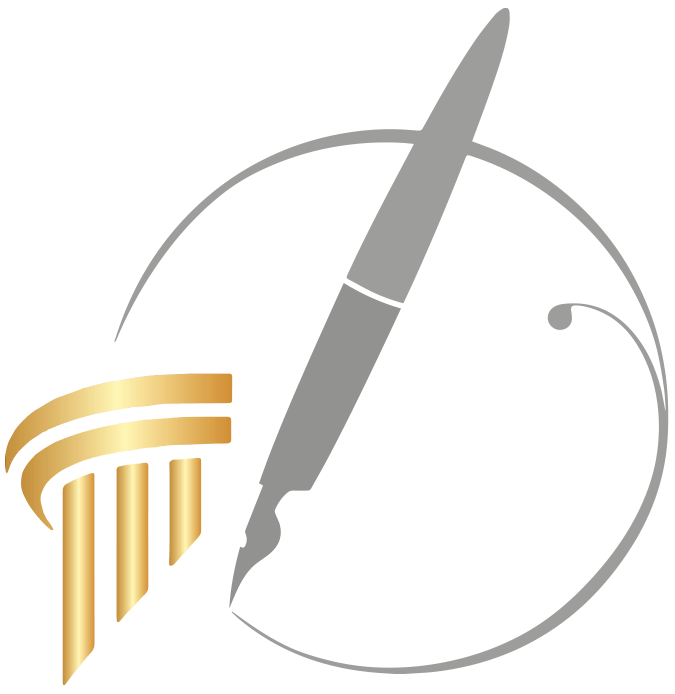Nell’ambito di una pronuncia articolata, che affronta diversi temi riguardanti la confisca disposta nei confronti sia della persona giudica sia della persona fisica (in relazione a ipotesi di autoriciclaggio), la Suprema Corte ha approfondito una problematica molto significativa nella prassi. In particolare, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è (nuovamente) interrogata sulla legittimità della confisca disposta a carico dell’ente ex art. 19 D. Lgs. 231/2001, allorché detto aspetto non sia stato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti in sede di applicazione della pena (c.d. “patteggiamento”). La Corte, aderendo ad un orientamento non uniforme (viene richiamata una recente decisione, la n. 30604/2024 della VI Sezione, di segno contrario), ha ritenuto che: la confisca di cui all’articolo 19 non sia nella disponibilità delle parti ed è irrilevante, ai fini della sua applicazione, che non sia stata oggetto dell’accordo; in caso di accordo che riguardi anche la confisca, il giudice può disattenderne i contenuti, esponendo le ragioni per cui si è discostata dal contenuto dell’intesa intervenuta tra il Pubblico Ministero e la difesa; al verificarsi del presupposto per la confisca (obbligatoria o facoltativa), il giudice è tenuto ad applicarla, a prescindere dall’intervenuto accordo tra le parti. Il testo della pronuncia è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20250205/snpen@s20@a2025@n04753@tS.clean.pdf
Contraffazione di marchi e segni distintivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12365/2025 ribadisce alcuni concetti in materia di contraffazione evidenziando, quanto al reato di cui all’art. 474 c.p., che, ai fini della sua sussistenza, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici (nel caso esaminato dalla sentenza si trattava di cellulari), non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. Più in generale, viene nuovamente chiarito che il concetto di contraffazione presuppone la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un marchio o di un segno distintivo, mentre per alterazione (costituente parimenti condotta punibile a norma degli artt. 473 e 474 c.p.), si intende la riproduzione solo parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originario o con il segno distintivo. La sentenza in commento sottolinea altresì che più il marchio gode di rinomanza (circostanza che nella disciplina civilistica lo rende tutelabile, a norma dell’articolo 20 lettera c) del codice di proprietà industriale, a prescindere addirittura da ogni confondibilità del segno e dal settore merceologico in cui si colloca il prodotto) più lo stesso è dotato di una forte capacità distintiva, con la conseguenza che, nella valutazione complessiva dei segni posti a raffronto, eventuali elementi di differenziazione aventi carattere secondario presenti nei segni contraffattori non incidono sulla positiva valutazione di falsità. https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20250331/snpen@s50@a2025@n12365@tS.clean.pdf
L’abrogazione dell’abuso d’ufficio non è incostituzionale – Comunicato della Corte Costituzionale
All’esito dell’udienza dello scorso 7 maggio, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale, sollevate da diverse Autorità Giudiziarie, aventi ad oggetto l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. Nelle prossime settimane si conosceranno le motivazioni della decisione. Il Comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale è visualizzabile al seguente link: https://cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20250508120025.pdf
Circolare sulle procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni di guida
Lo scorso 11 aprile 2025 è stata emessa la Circolare che si allega, a firma congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute. Il provvedimento è teso a fornire indicazioni sulle procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni di guida dopo l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della Strada. In sostanza, gli accertamenti previsti dalla Circolare sono funzionali a provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un momento prossimo alla guida, cosicché si possa ritenere che la sostanza produca ancora effetti durante la guida. Quanto alla metodica di analisi, volta ad accertare la presenza dei principi attivi, la Circolare prescrive che debbano essere effettuate esclusivamente su campioni ematici o di fluido del cavo orale (proprio perché rappresentano le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida). Risultano di particolare interesse gli allegati alla circolare, consistenti in direttive specifiche che tengono conto delle metodiche analitiche più recenti riferendosi, in particolare, alle modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale (direttiva 1) nonché alle procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forsensi presso le strutture sanitarie sia in occasione dei servizi di controllo ordinari che a seguito di incidente stradale (direttiva 2). Il testo della circolare, così come dei suoi allegati, può essere di seguito visualizzato: circolare-prot-n.300.strad_.1.0000011280.u.2025-dell-11.04.2025
Abusi e violenza nello sport – Università degli Studi di Milano
In data 29 aprile 2025 si è tenuto un incontro organizzato dall’Università degli Studi di Milano nel corso del quale è stato trattato il delicato tema degli abusi e della violenza nello sport.
Incontro di Studi sul processo penale telematico
Lo scorso 31 marzo 2025 ha avuto luogo un rilevante convegno in materia di processo penale telematico focalizzato, in particolare, sull’obbligo del deposito secondo tali modalità a partire dal 1 aprile 2025. Nel corso dell’incontro si è ampiamente fatto riferimento tanto alle potenzialità nuove del sistema quanto alle sue ancora attuali problematicità, senza dimenticare di dare rilievo agli orientamenti giurisprudenziali sinora pubblicati. https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202503/20250327094315108074788962.pdf
Riforma del Codice della Strada – Legge 177/2024
La legge del 25 novembre n. 177/2024 ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada, finalizzate a migliorare la sicurezza stradale e, più in generale, la mobilità. Le modifiche adottate non hanno modificato i limiti grammo/litro entro cui è consentito guidare (ovvero i canonici 0,5 g/l) né i limiti relativi alle fasce di cui alle lettere “A-B-C” (che prevedono differenti trattamenti sanzionatori a seconda del tasso alcolemico rilevato) ma all’art. 186 cds sono stati aggiunti due nuovi commi, e in particolare il 9 ter e il 9 quater. Il primo così dispone: “9 ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo”. Il secondo, invece, così recita: “9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli”.
Inapplicabilità dell’art. 603 bis c.p. al lavoro intellettuale – Cass. Pen. 43662/2024
F. Riboldi, Inapplicabilità dell’art. 603 bis c.p. al lavoro intellettuale: una chiara presa di posizione della Corte di cassazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 12 L’Autore commenta una recentissima sentenza della Suprema Corte, relativa al caporalato e pubblicata lo scorso 28 novembre 2024 Il testo dell’articolo è reperibile al seguente link: Inapplicabilità dell’art. 603 bis c.p. al lavoro intellettuale: una chiara presa di posizione della Corte di cassazione – Giurisprudenza penale
Processo Penale Telematico
Convegno – Tutte le novità del processo penale telematico – Si estende l’obbligo del portale? Ordine degli Avvocati di Milano – Salone Valente M. Troglia, Regole del processo penale telematico e codice di procedura penale: profili di frizione
Prova digitale, perquisizioni informatiche e Trojan
Convegno di Studi – La Prova digitale – Le perquisizioni informatiche – Trojan e malware nella raccolta di prove digitali Corte di Appello di Brescia F. Riboldi, Captatore informatico e softwares di supporto alle indagini: evoluzione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali